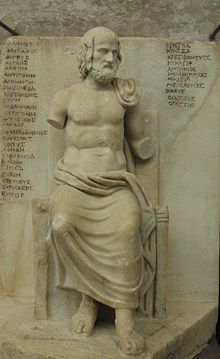Prima guerra persiana - Civiltà Greca


Menu principale:
Prima guerra persiana
Storia > Guerre persiane
I persiani verso l'Occidente
Ciro e la conquista della Lidia
A partire dalla metà del VI secolo a.C. l'intera area del Mediterraneo orientale fu investila dall'espansione dell'Impero persiano. I sovrani che governavano quella vasta struttura politica, gli Achemenidi, avevano fatto propria un'ideologia che voleva i persiani destinati a imporre la propria egemonia su tutti i popoli della Terra: ecco perché a partire dal fondatore dell'impero, Ciro il Grande, tutti i successivi Achemenidi organizzarono grandi campagne di conquista, che spostarono progressivamente più a ovest i confini dei territori dominati.
Decisiva ai fini del contatto con il mondo greco fu in particolare la sottomissione, avvenuta nel 547- 546 a.C., del Regno di Lidia, che aveva a sua volta inglobato al proprio interno nei decenni precedenti molte colonie greche sulla costa dell'Anatolia.
Il più celebre fra i sovrani della Lidia, il ricchissimo Creso, era in rapporti di grande familiarità con la cultura greca e con le aristocrazie che controllavano le πόλεις: secondo un'antica tradizione, lo stesso Solone avrebbe fatto visita alla sua corte nel corso dei viaggi intrapresi all'indomani delle riforme attuate ad Atene; inoltre, alla vigilia dello scontro con i persiani il sovrano lidio avrebbe interrogato l'oracolo di Delfi circa l'esito della guerra,
come avrebbe fatto qualsiasi polis ellenica. Con la conquista persiana i greci d'Asia entrarono invece a contatto con un potere nuovo e potenzialmente minaccioso, anche se in un primo momento essi non videro peggiorare le proprie condizioni di vita.
I regni di Cambise II e Dario I Serie preoccupazioni destò invece nelle colonie la conquista dell'Egitto (525 a.C.) da parte di Cambise II, successore di Ciro: sebbene i persiani non ne limitassero formalmente le attività commerciali, i greci si videro infatti preclusi gli scambi con il paese sul Nilo, ai quali avevano affidato la speranza di traffici redditizi.
I timori crebbero con il successore di Cambise,
Dario I, che conquistò la regione della Propontide (I odierno mar di Marmara), la Tracia e rese tributario il Regno di Macedonia, posto ai confini nord-orientali del mondo greco. Il dominio
persiano si profilava ormai come un’ombra minacciosa e incombente e, date le ambizioni espansionistiche della monarchia achentenide, non era difficile prevedere che la Grecia sarebbe stata il prossimo obiettivo dell'espansionismo di Dario.
L’atteggiamento verso le città della Ionia
Alle πόλεις gieche che via via sottomettevano, i persiani imposero pesanti tributi, sia economici sia militari, costringendole a partecipare con contingenti di navi e di soldati alle azioni belliche volute dal sovrano. Il pericolo più grave che incombeva sulla politica interna delle colonie era tuttavia quello del riaffacciarsi delle tirannidi, che venivano incoraggiate dai re achemenidi. Le città greche non tollerarono però a lungo la pesante mano persiana e la riduzione dei loro spazi di libertà.
La rivolta ionica e la risposta di Dario
La spedizione contro Nasso
Nel 500 a.C il tiranno di Mileto, Aristagora, progettò la conquista dell'isola di Nasso. Per questa impresa trovò l’appoggio del persiano Artaferne, satrapo di Sardi, al cui territorio apparteneva la stessa Mileto: Artaferne era infatti a sua volta interessato a una conquista che avrebbe aperto ai persiani la possibilità di controllare l’arcipelago delle Cicladi. di cui Nasso faceva parte. Nonostante la superiorità numerica, le truppe miste ionico-persiane non riuscirono a vincere la tenace resistenza dell’isola e l’impresa si risolse in un clamoroso fallimento.
La rivolta antipersiana
Per sottrarsi alla punizione da parte di Dario I per il fallimento. Aristagora decise allora, nel 499 a.C., di deporre la carica di tiranno e di mettersi a capo di una rivolta contro la Persia. Egli chiese sostegno alle πόλεις del continente, e in primo luogo a Sparta, riconosciuta come la città militarmente più forte della madrepatria. Gli spartani erano però restii a impegnarsi lontano dal Peloponneso e per di piu stavano combattendo in quel momento contro la rivale Argo; altri centri, come Corinto, rifiutarono perché non avevano interesse a prestare aiuto alle πόλεις ioniche, loro concorrenti nei commerci. Atene invece, preoccupata per l’appoggio fornito dai persiani all’ex tiranno Ippia e per i propri interessi commerciali nel mar Nero, assicurò il suo contributo, che fu però esiguo - appena una ventina di navi -, e un minuscolo contingente fu mandato da Eretria. Tuttavia, per opporsi al Gran re - cosi i greci chiamavano il monarca persiano - ci voleva ben altro.
La distruzione di Mileto
L'iniziale vittoria greca, culminata nella distruzione di Sardi, fece solo crescere nei persiani il desiderio di infliggere ai ribelli una punizione esemplare: nel 494 a.C. Mileto, origine dell’insurrezione, fu rasa al suolo, mentre i suoi abitanti furono trucidati o deportati. Veniva cosi distrutto un centro fondamentale della vita intellettuale greca: a Mileto. culla della filosofìa, per la prima volta nella storia dell’Occidente gli uomini avevano tentato di indagare razionalmente l'universo, lì, inoltre, erano nati i primi studi riguardanti il passato, essenziali allo sviluppo della storiografia.
Le mire di Dario sulla Grecia
Una volta repressa la rivolta, Dario cominciò a organizzare una spedizione punitiva contro Atene ed Eretria, colpevoli di aver interferito in questioni interne al suo impero: a spingerlo era, tra l'altro, Ippia, l'ex tiranno di Atene che presso il Gran re aveva trovato asilo e che sperava di riprendere il potere sulla città con il suo aiuto e con l'appoggio dei sostenitori che gli erano rimasti in Attica II progetto di Dario era tuttavia molto più ambizioso e la punizione era soltanto un pretesto: egli puntava infatti a dominare la Grecia intera.
La prima guerra persiana
Le fazioni politiche ad Atene
Di fronte all'imminente attacco persiano la classe dirigente ateniese si divise in due fazioni: alcuni giudicavano perduto in partenza un confronto militare con Dario ed erano favorevoli a scendere a compromessi; peraltro al contrario, bisognava accettare il rischio e prepararsi allo scontro. L'elezione ad arconte di Temistocle, nel 492 a.C., fece prevalere il fronte antipersiano. Ma l'intelligenza politica e militare di quest'ultimo avrebbe brillato più avanti; in quel frangente fu infatti oscurata dalla figura di Milziade, un aristocratico rientrato ad Atene dopo che i persiani avevano scacciato la sua famiglia dal Chersoneso tracico (una regione dell'attuale Turchia).
Atene e Sparta di fronte alla guerra
La campagna offensiva del Gran re iniziò nel 490 a.C.
La flotta persiaria, comandata dai generali Dati e Artaferne e accompagnata dallo stesso Ippia, prima sottomise le Cicladi, quindi puntò verso l'Eubea, dove Eretria fu assediata e incendiata e i suoi abitanti vennero ridott in schiavitù: Infine, nel settembre dello stesso anno le navi persiane approdarono nella piccola baia di Maratona, sulla costa dell'Attica, non lontano da Atene.
La risposta militare non poteva dunque essere ulteriormente rimandata. Tra i dieci strateghi ateniesi prevalse la posizione di Milziade, che propose di non aspettare l'attacco dei nemici, ma di andare loro incontro per affrontarli in campo aperto, contando sulla superiorità militare degli opliti. Nel frattempo, una delegazione ateniese fu inviata a Sparta per chiedere l'invio di truppe, ma dalla città peloponnesiaca ottenne soltanto una promessa; gli spartani risposero infatti che non sarebbero partiti finché non fossero termininate le celebrazioni in onore di Apollo: una giustificazione religiosa che celava probabilmente la tradizionale riluttanza dei Lacedemoni a impegnarsi militarmente al di fuori del Peloponneso.
La battaglia di Maratona
Non rimaneva tempo da perdere. Gli ateniesi furono appoggiati solo da un contingènte di 1000 soldati inviati dalla città beotica di Piatesi, loro alleata, e affrontarono i persiani contando sulla propria superiorità tattica. I soldati del Gran re erano infatti più numerosi (probabilmente il doppio degli ateniesi, che schierarono 10000 uomini), ma combattevano in ordine sparso, mentre la forza della falange oplitica consisteva nell'attacco frontale al nemico, per scompaginarne le file e costringerlo alla ritirata.
La battaglia di Maratona nella tarda estate del 490 a.C. si risolse così in una disfatta per le truppe di Dario I: i persiani persero oltre 6000 uomini; a fronte dei 192 caduti ateniesi, e quando cercarono di arrivare ad Atene dal mare e di coglierla indifesa trovarono ad attenderli gli opliti, che, a marce forzate, in brevissimo tempo erano tornati da Maratona. Senza altri indugi i nemici decisero di ritirarsi e di abbandonare la Grecia. Sul piano del prestigio, Atene usciva molto più che vincitrice: aveva combattuto praticamente da sola contro un nemico all'apparenza invincibile, un elemento dal quale la città non tardò a trarre tutto il possibile vantaggio nei confronti degli altri greci.
Home Page | Introduzione | Letteratura arcaica | Letteratura ellenistica | Letteratura classica | Storia | Mitologia | Mappa generale del sito